
 |
Dobbiamo arrivare in Italia per trovare la prima speculazione circa il contenuto di quella zona di cielo proibita. Nell'ultimo libro del "De Republica" di Cicerone, l'autore immagina un sogno di Scipione l'Emiliano, durante l'assedio di Cartagine, nel 149 a.C. Suo nonno, il grande Scipione l'Africano, gli apparve dinnanzi, e in qualche modo lo condusse in un punto della Via Lattea. Secondo le parole stesse del giovane Scipione: "Ex quo omnia mihi contemplanti praeclara cetera et mirabilia videbantur. Erant autem eae stellae, quas numquam ex hoc loco vidimus, et eae magnitudines omnium, quas esse numquam suspicati sumus". ("Guardando dalla posizione in cui mi trovavo, l'intera vista mi parve meravigliosamente bella. Vi erano stelle che noi non abbiamo mai visto da questo luogo, ed esse erano più grandi di quanto potremmo mai immaginare").
Il "De Republica" di Cicerone è andato perduto durante il
Medio Evo, con l'eccezione del Sogno di Scipione, che si è conservato in un
Commentario scritto a Roma da Macrobio, alla fine del quarto secolo. In quel
libro Macrobio non lascia alcun dubbio sul fatto che Scipione stia parlando
delle stelle vicine al Polo Sud, che non erano state mai viste dal mondo romano.
Questo Commentario fu molto letto nei circoli medievali. Probabilmente ispirò
Dante Alighieri (tredicesimo secolo), che nella sua Divina Commedia,
all'inizio del Purgatorio (Canto I), pronuncia queste misteriose
parole:
| I' mi volsi a man destra, e puosi mente a l'altro polo, e vidi quattro stelle non viste mai fuor ch'a la prima gente. Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: oh settentrional vedovo sito, poi che privato se' di mirar quelle! |
Sorprendentemente, questa affermazione risulta assolutamente vera! Infatti, vi sono esattamente quattro stelle di prima grandezza (a e b Centauri, e a e b Crucis) che erano state osservate dai Greci, ma che non potevano essere più viste dal Mediterraneo Settentrionale, ai tempi di Dante. E lui, da dove aveva ottenuto questa informazione? Si tratta forse di una tradizione antica, che però non è giunta fino ai nostri tempi? Qualche viaggiatore arabo gliene aveva fatto menzione? Oppure si era ispirato alle quattro virtù cardinali, come si legge in qualche annotazione delle opere di Dante? Quelle quattro stelle di prima grandezza facevano parte probabilmente del catalogo stellare incluso nell'Almagesto di Tolomeo, che circolava in Europa (in traduzione latina) già un secolo prima della nascita di Dante. Tuttavia è improbabile che sia stata questa la sua fonte, poiché quelle stelle, anche se presenti nel catalogo, sono grossolanamente mal posizionate e soltanto una di esse (a Centauri) è indicata come stella di prima grandezza.
Vi è un altro riferimento astronomico nel
Purgatorio di Dante, e anch'esso non è ben chiaro. Riguarda comunque la
nostra storia, come vedremo in seguito. L'osservazione delle quattro stelle è
avvenuta appena prima dell'alba. Dopo che era trascorsa una lunga giornata,
si era fatto buio di nuovo. Tra Virgilio e l'autore si svolge allora questo
dialogo (Canto VIII):
| E 'l duca mio: «Figliuol, che là sù guarde?». E io a lui: «A quelle tre facelle di che 'l polo di qua tutto quanto arde». Ond'elli a me: «Le quattro chiare stelle che vedevi staman, son di là basse, e queste son salite ov'eran quelle». |
Quattro luminose stelle e tre 'torce' vicino al polo sud! Hanno avuto qualche influenza sulle generazioni future? Continuiamo la nostra storia.
La nostra successiva informazione circa le stelle australi proviene dal famoso Amerigo Vespucci, l'esploratore che diede il suo nome al Nuovo Mondo. In una lettera che racconta di un viaggio che probabilmente avvenne nel 1499, egli sostiene di aver seguito la costa del Brasile fino a un punto a 6° a sud dell'Equatore. Egli cercò invano la stella del polo sud, ma non ne trovò nessuna più vicina di 10° dal polo (infatti, la stella di 3a magnitudine b Hydri si trovava proprio a quella distanza nel quindicesimo secolo). Allora si ricordò delle parole di Dante nel Purgatorio, a proposito delle quattro stelle luminose. Dopo aver riportato quei versi integralmente, aggiunge: "secondo che mi pare che il Poeta in questi versi voglia descriver per le 'quattro stelle' el polo dello altro firmamento, e non mi diffido fino a qui che quello che dice non salga verità: perché io notai 4 stelle figurate come una mandorla, che tenevano poco movimento". Più avanti nella lettera viene detto che queste osservazioni sono state effettuate in Luglio e Agosto. In quel periodo dell'anno, la Croce ha già superato il meridiano, in una posizione inclinata, e non è facilmente identificabile con una croce. La Croce del Sud ha la forma di una mandorla? Non possiamo dirlo con certezza.
In una successiva lettera ("Mundus Novus", scritta in
latino , e poi tradotta un po' liberamente in italiano da G.B. Ramusio nel
1550), Amerigo Vespucci ci parla di un altro viaggio, in cui ebbe una migliore
opportunità di osservare le stelle australi. Nella sua narrazione egli dice di
aver raggiunto una latitudine di 50° sud. Dedica poi vari paragrafi e un paio
di schizzi al cielo australe. Inizia dicendo di aver notato circa 20 stelle
luminose quanto Venere o Giove. Quindi menziona di aver visto anche tre "canopi"
in quelle regioni, due di essi luminosi e l'altro oscuro. La regione vicina al
polo è descritta con queste parole: "Tres sunt habentes trigoni orthogoni
schema, quarum dimidia peripherie diametrus gradus habet novem semis".
("Vi sono 3 stelle a forma di triangolo ortogonale, poste su una circonferenza
con un semidiametro di 9.5°."). Quindi passa a parlare del primo dei canopi
luminosi e ne fornisce un disegno approssimativo, insieme alle 3 stelle che
formano il triangolo. Due altre stelle si trovano oltre questo gruppo, e che
ruotano ad una distanza di 12.5° dal polo. Esse sono seguite da un secondo
canopo luminoso. La sua descrizione continua con le parole: "Hiis succedunt
alie sex stelle formosissime et clarissime inter omnes alias octave sphere,
que in firmamenti superficie dimidiam habent peripherie diametrum graduum
triginta duorum. Cum hiis pervolat unus canopus niger immense magnitudinis.
Conspiciuntur in Via Lactea et huiusmodi figuram habent quando sunt in meridionali
linea." ("Dopo questo segueno sei altre lucenti stelle, le quali di splendore
avanzano tutte le altre che sono nella ottava sfera, delle quali quella che è
nel mezo nella superficie della detta sfera ha di misura di circonferenza gradi
trentadue. Dopo queste seguita un gran canopo, ma fosco. Le quai tutte si veggono
nella Via Lattea, e giunte alla linea meridiana mostrano la sotto scritta figura:").
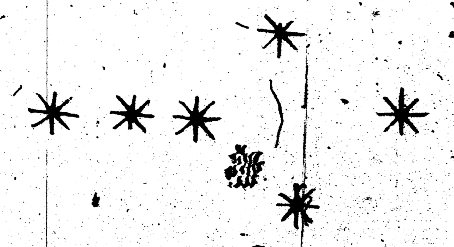 |
Benché sia un po' dubbia l'identificazione dei 2 'canopi' luminosi con le Nubi di Magellano, sicuramente la figura qui mostrata rappresenta la Croce del Sud seguita da b e a Centauri. La distanza dal polo celeste, il fatto che in nessun altra zona di cielo si trovi una tale concentrazione di stelle di prima magnitudine e, soprattutto, la collocazione del canopo nero esattamente dove si trova la nebulosa 'Sacco di Carbone', sono tutti argomenti a favore dell'identificazione proposta. Vi è però qualche altra considerazione che contrasta con questa interpretazione. Alcuni studiosi ritengono che questa lettera sia un falso e che Vespucci non sia mai arrivato a quelle latitudini così meridionali. Le sue descrizioni geografiche sono vaghe, come lo sono pure quelle del canopi luminosi. Le altre sue osservazioni astronomiche non aggiungono molto alla sua credibilità. Per esempio, egli dice che per due volte l'intero equipaggio ha visto l'arcobaleno verso mezzanotte, o che in quelle regioni la Luna Nuova era visibile lo stesso giorno della sua congiunzione con il Sole. Un'altra possibilità è che Vespucci abbia scritto la lettera molti anni dopo il viaggio, in un tempo in cui non aveva più con sé i suoi appunti, che, come dice egli stesso, erano stai consegnati al Re del Portogallo.
Torniamo ora alla nostra storia. A che punto siamo? Descrizioni di un Carro del Sud, di una mandorla, di un triangolo, di 'canopi', ma neanche una parola che nomini una croce. In effetti, nessuno di questi asterismi è stato riportato nel primo 'moderno' atlante stellare, una incisione dell'artista tedesco Albrecht Dürer, realizzata nel 1515. In questo atlante la zona di cielo non visibile nel periodo ellenistico è ancora lasciata vuota, grossolanamente un cerchio un po' eccentrico rispetto al polo sud del sedicesimo secolo.
Pigafetta tenne un diario durante tutto il viaggio. In esso ci viene raccontato dei giganteschi abitanti della Patagonia e della loro lingua, dei 3 mesi di navigazione attraverso l'Oceano Pacifico senza vedere mai una terra abitata, della morte del loro comandante nelle Filippine, e infine del lungo viaggio di ritorno a casa, navigando verso ovest intorno alla punta meridionale dell'Africa. Ma Pigafetta ebbe anche il tempo di scrivere qualcosa a proposito delle stelle. In reminiscenze successive, aggiunte al suo diario dopo la traversata del Pacifico, Pigafetta dice: "Il polo antartico non è così stellato como lo artico. Se vede molto stelle piccolle congregate insieme che fanno in guiza de due nebulle poco separate l'una de l'altra e uno poco ofusche, in mezo de le qualle stanno due stelle non molto grandi né molto relucenti e poco se moveno." Suppongo che le due nebulose si riferiscano alle Nubi di Magellano, mentre le due stelle grandi ma non molto luminose siano l'ammasso globulare 47 Tucanae, vicino alla Piccola Nube, e la nebulosa della Tarantola nella Grande Nube di Magellano.
Dopo una digressione circa la deviazione della bussola dal Nord vero, egli prosegue dicendoci che in quei mari avevano visto una croce di cinque stelle molto luminose, dritte ad ovest e bene aggiustate tra loro. Le sue esatte parole sono: "Quando éramo in questo golfo vedessimo una croce de cinque stelle lucidissime, dritto al ponente e sono giustissime una con l'altra." Finalmente una croce, descritta da un testimone alquanto attendibile! Ovviamente deve trattarsi della nostra Croce del Sud, che cos'altro altrimenti? Ma possiamo esserne sicuri? Verifichiamo la sua descrizione.
Magellano uscì dallo stretto il 28 Novembre 1520. Per la fine di Gennaio, dovrebbero aver lasciato l'emisfero australe. La croce di Pigafetta è stata probabilmente osservata in Dicembre o all'inizio di Gennaio. Le notti a quelle latitudini sono brevi. Infatti, durante il passaggio attraverso lo stretto, non si erano mai trovati immersi in una oscurità completa. E' possibile che abbiano visto la Croce del Sud situata 'dritta al ponente'? Potete fare questo esercizio voi stessi, con qualunque programma di simulazione astronomica disponibile sul mercato. Vi sorprenderete di scoprire che in quel tempo la nostra Croce era posizionata nel cielo sud-orientale. Noterete inoltre che, anche se vi sono cinque cospicue stelle nella Croce, soltanto tre di esse (a, b e g) sono realmente luminose, con magnitudini comprese tra 1.0 e 1.6. La quarta stella (d) è di 3a magnitudine, e la quinta (e) è di oltre una magnitudine più debole. E, dopotutto, soltanto le prime quattro stelle si dispongono a formare una croce, come si può facilmente vedere nella bandiera dell'Australia.
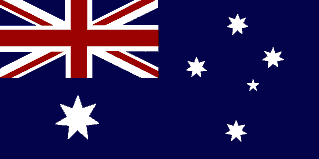 |
E se le parole 'dritto al ponente' significassero veramente qualcosa come 'puntato esattamente verso ovest'? Durante la lenta rotazione in senso orario attorno al polo celeste, ci sarà un momento in cui la Croce è vista orizzontale, e il suo braccio più lungo (g -> a) punta verso ovest. Dobbiamo anche essere preparati ad accettare che l'espressione 'sono giustissime una con l'altra' significhi semplicemente che le cinque stelle erano raggruppate in una piccola zona di cielo, senza necessariamente implicare una descrizione delle loro posizioni relative. Qualunque sia il caso, vi sono pochi dubbi sul fatto che la maggior parte degli Europei sentirono parlare della Croce per la prima volta, quando lessero il racconto dell'incredibile circumnavigazione del globo terrestre.
Non è stato tuttavia Pigafetta il primo europeo a scrivere a proposito della Croce. Non c'è da sorprendersi che sia stato un altro italiano, come tutti i principali personaggi della mia storia fino a questo momento. Mentre Spagnoli e Portoghesi stavano svelando la 'terra incognita' delle antiche mappe, sembra che furono gli Italiani i veri scopritori del cielo australe. Il nome di questo personaggio era Andrea Corsali. Era un diplomatico fiorentino, che in qualche modo riuscì a trovarsi a bordo di una nave portoghese, inviata dal Re Manuel per effettuare lo scambio di ambasciatori con il mitico Prete Gianni, il Re Cristiano di Etiopia, la quale per molti secoli era rimasta completamente isolata dagli altri Cristiani.
In una lettera inviata a Giuliano de' Medici, scritta in India il 6 Gennaio
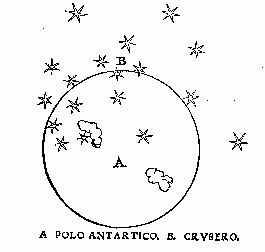 |
Le informazioni fornite da Corsali sono di gran lunga più accurate di tutti i riferimenti citati finora, e non lasciano alcun dubbio sull'identificazione. Ritengo anche possibile che Pigafetta abbia visto la lettera di Corsali, prima di scrivere la versione finale del suo diario, traendo da quella lettera le proprie informazioni. Non sto dicendo che Pigafetta non abbia visto la Croce, ma forse non aveva preso appunti in proposito, durante il viaggio, e i suoi ricordi, dopo tanti anni, erano un po' confusi.
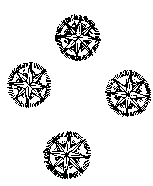 |
Considerando che il diario di Pigafetta è stato completato alla fine del 1524, e che circolava soltanto in forma di manoscritto, è quasi sicuro che Fernández de Oviedo, che aveva iniziato a scrivere la sua Storia vari anni prima, aveva conosciuto la Croce indipendentemente da Corsali o da Pigafetta.
Da un altro libro, scritto alcuni anni dopo, nel 1538, si desume che la Croce del Sud fosse facilmente riconosciuta dai marinai dei mari australi. Nella Cosmografía dello spagnolo Pedro de Medina, il primo manuale di navigazione che sia stato scritto, la Croce è usata allo stesso modo in cui è usata la Polare nell'emisfero settentrionale, per trovare la latitudine in mare. Le parole di Medina sono: "E' necessario sapere che i segni per riconoscere il Polo Antartico sono quattro stelle disposte a forma di croce. Queste stelle non sono uno dei segni dello Zodiaco, e nemmeno una delle 35 costellazioni del cielo. Il loro nome è 'Crucero'. Una di queste quattro stelle è chiamata la testa, un'altra il piede, e le altre due le braccia. Per riconoscerle una dall'altra, dovete sapere che quella al piede è più luminosa delle altre. Quando la croce è in posizione diritta, la stella al piede è più vicina all'orizzonte, e la sua distanza dal Polo Antartico è di 30 gradi."
Per concludere questa parte di narrazione, desidero aggiungere un'ultima
citazione, non per il suo valore di documento, ma per la sua bellezza
letteraria. E' tratta dalle Lusiadi, il grande poema epico portoghese scritto
da Camoens nel 1572. I seguenti versi probabilmente si riferiscono alla
Croce:
| "Já descoberto tínhamos diante, Lá no novo Hemisfério, nova estrela, Não vista de outra gente, que ignorante Alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante, E, por falta de estrelas, menos bela, Do Pólo fixo, onde ainda se não sabe Que outra terra comece, ou mar acabe." |
"Discoperto noi abbiamo finalmente, in quel nuovo emisfero, nuova stella, non ancora mai vista da altra gente, da lungi ignari che vi fosse quella. Abbiam visto la parte men lucente, e, per mancanza di stelle, men bella, di quel polo celeste, e niuno sa se altra terra inizia, o mar finirà." |
Abbiamo visto come la Croce del Sud sia divenuta nota alla maggior parte dei marinai intorno al mondo e a molti uomini colti in Europa. Questa dovrebbe essere la fine della storia, ma in realtà non lo è. La parte più appassionante deve ancora venire. Mi riferisco alla faticosa e tortuosa via, attraverso la quale la conoscenza dei cieli australi arrivò all'attenzione della comunità scientifica. Ci crediate o no, sembra che gli astronomi europei abbiano avuto una conoscenza molto scarsa della Croce per quasi tutto il secolo. Gli studiosi erano troppo occupati a riscoprire le antichità, per perdere il loro tempo con il mondo reale. Essi davano più peso a una frase di Aristotele o di Tolomeo, che alle notizie che arrivavano dalle terre appena scoperte. Se nel 1610 essi negavano la realtà delle macchie sul Sole, o delle lune di Giove, visibili attraverso il telescopio di Galileo, perché avrebbero dovuto credere a stelle che non avevano mai visto?
La prima descrizione conosciuta del cielo stellato è un poema greco intitolato Phaenomena, scritto nel 270 a.C. da Arato di Soli. Questo poema include una completa descrizione delle costellazioni note agli
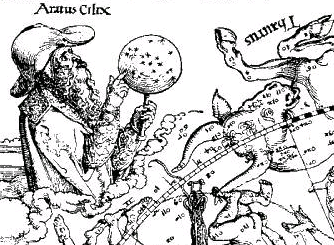 |
Seguirono altre descrizioni letterarie. Fu solo questione di tempo perché la forma delle costellazioni fosse rappresentata graficamente. La più nota rappresentazione di questo genere, che si è conservata fino ai nostri giorni, è l'Atlante Farnese, del 200 a.C. Si tratta di un globo celeste portato sulle spalle dal gigante Atlante, con le raffigurazioni mitologiche delle costellazioni rappresentate in rilievo sulla sua superficie. Tra l'altro, è questo il motivo per cui, fin da allora, ogni rappresentazione del globo celeste o terrestre è chiamata 'atlante'. Il povero gigante non ha faticato invano!
Alcuni manoscritti, che ci sono giunti dal Medio Evo, contengono rappresentazioni delle costellazioni. Le bellissime figure decorate, tuttavia, non hanno quasi alcun valore scientifico. Le singole stelle non sono riportate, oppure, se vi compaiono, non hanno alcun rapporto con le stelle reali. Quando, nel sedicesimo secolo, divenne evidente l'importanza delle stelle per la navigazione, questo tipo di rappresentazioni risultò del tutto inutile. L'osservazione delle stelle consente una valutazione accurata della latitudine e, in alcuni casi, anche una grossolana conoscenza della longitudine. Senza una buona mappa stellare, non era facile per i naviganti trovare la giusta stella nel cielo. Ci crediate o no, Colombo, l'Ammiraglio del Mare Oceano, fece un errore nell'identificazione della Polare, e calcolò la latitudine delle Antille come quella di New York!
Abbiamo già menzionato il primo atlante stellare moderno di Albrecht Dürer.
|
|
|
|
La fantasia di chi disegnava le mappe del cielo non si fermava qui. Un'altra costellazione ancora più strana ha trovato posto nella zona che precedentemente era vuota. Mi è stata fatta notare dal mio amico Ray Harris, un esperto di antiche mappe stellari. In effetti è stato lui ad attirare la mia attenzione su questo argomento, e mi ha fornito la maggior parte delle informazioni connesse con questa parte della mia storia. Questa costellazione è una figura umana posta vicino al Polo Sud, dal nome molto appropriato di Polophylax, che in greco significa Guardiano del Polo. Penso che il suo scopo fosse quello di costituire una controparte australe della costellazione dell'Arctophylax (nota anche come Bootes), che significa Guardiano delle Orse.
Cerchiamo di ricapitolare. All'inizio dell'era delle scoperte, la conoscenza del nostro globo e dei cieli era derivata quasi completamente dai due classici testi di Tolomeo: la Geografia e l'Almagesto. Il primo conteneva una descrizione piuttosto imprecisa di meno di un quarto della superficie terrestre, riportando soltanto l'Europa centrale e meridionale, l'Africa a nord del Sahara e una parte dell'Asia occidentale e meridionale. L'Almagesto, invece, era già in grado di mostrare tutte le stelle di una certa importanza, visibili ad occhio nudo, coprendo più dell'85% dell'intera volta stellata.
Un secolo e mezzo dopo, la geografia aveva ampliato enormemente la conoscenza della Terra. I globi e le mappe terrestri mostravano completamente nuovi continenti e immensi oceani mai sognati prima. L'astronomia, al contrario, non aveva fornito nessun dato nuovo, e le uniche aggiunte che i cartografi celesti riuscirono a fare furono poche costellazioni mal posizionate o immaginarie, basate su rapporti ambigui di naviganti, scritti molti decenni prima.
I cartografi si rivolsero all'astronomia per avere aiuto. Nel caso delle stelle visibili dall'Europa, essi richiesero un nuovo catalogo stellare con meno errori di quelli contenuti nell'Almagesto, e con posizioni più accurate. Per le stelle del cielo australe, essi avevano bisogno di misure per sostituire le relazioni puramente descrittive, ricevute dai naviganti. La prima richiesta fu soddisfatta dal lavoro del più grande astronomo di quel periodo, Tycho Brahe, che fin dal 1575 aveva osservato con una accuratezza senza precedenti le stelle visibili dalla sua nativa Danimarca. Ma non vi era un Tycho nell'emisfero australe.
Un intraprendente olandese trovò una tipica soluzione commerciale. Se non vi è un Tycho australe, facciamone uno! Abbiamo già incontrato questo personaggio. E' lo stesso Petrus Plancius che aveva posizionato (o mal posizionato) la Croce e il Triangolo Australe per la prima volta su un globo celeste, come pure alcune altre costellazioni del cielo boreale. Quando la prima spedizione olandese salpò per le Indie Orientali nel 1595, Plancius chiese al timoniere, Pietr Keyser, di effettuare delle osservazioni delle stelle australi con tecniche di avanguardia. Keyser, che osservò il cielo dal Madagascar e da Sumatra, morì durante il viaggio. Il suo lavoro fu però messo in ordine da Frederik de Houtman, il capo della spedizione, e inviato a Plancius. Houtman eseguì poi ulteriori e più perfezionate osservazioni durante un secondo viaggio, nel 1598, che pubblicò in forma di catalogo quando fece ritorno, alcuni anni dopo.
Disponendo di osservazioni aggiornate, Plancius organizzò la zona di cielo, non ancora riportata sulle mappe, in 12 nuove costellazioni. Riconobbe anche la posizione corretta della Croce. Le nuove costellazioni apparvero per la prima volta in un globo realizzato da Jodocus Hondius nel 1598, e in un altro globo successivo realizzato nel 1603 da Willem Blaeu, un ex-collaboratore di Tycho Brahe. Fu ancora nel 1603 che il bavarese Johannes Bayer pubblicò il suo famoso atlante stellare, introducendo per la prima volta l'uso delle lettere greche per denotare le stelle più luminose di ogni costellazione.
Nell'atlante di Bayer il cielo era suddiviso in 48 tavole singole, una per ognuna delle costellazioni tradizionali, più un'altra tavola in cui erano raggruppate le nuove dodici costellazioni introdotte da Plancius.
 |
La spiegazione di tutto questo sembra che sia dovuta al fatto che Bayer non
usò per la Croce le nuove posizioni registrate dall'Olandese, ma quelle riportate
sul venerabile Almagesto. Infatti molte delle stelle riportate in questa parte
della mappa di Bayer sono poco riconoscibili in un moderno atlante stellare.
Usando il programma di simulazione astronomica Guide 8.0 di Project Pluto, con
l'opzione del Catalogo Stellare Almagesto che ho realizzata io stesso, ho
preparato una mappa con le stelle reali e quelle dell'Almagesto, riferite
all'epoca 1600. Sia l'orientazione della mappa che la griglia si riferiscono
alle coordinate eclittiche, per corrispondere alla mappa di Bayer. Le 2 stelle
luminose a sinistra sono a e b Centauri. La croce attuale è formata dalle quattro
stelle colorate, alla sinistra della scritta 'Cru'. Le stelle dell'Almagesto
sono rappresentate da dischi bianchi con dei raggi rosa in diagonale.
Probabilmente Bayer costruì la sua croce con le 4 stelle dell'Almagesto, quelle
più a sinistra delle 5 che si vedono nella parte inferiore della mia mappa,
benché le sue posizioni siano soltanto approssimate.
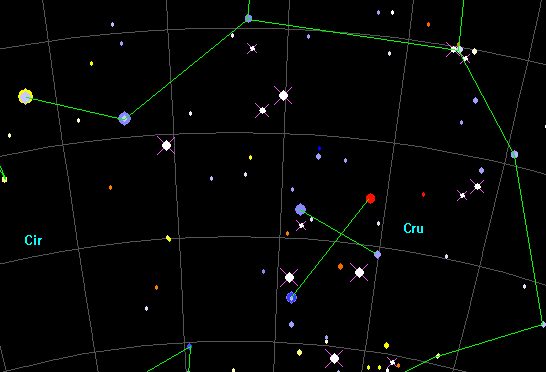 |
Il primo documento che ho visto, in cui sia raffigurata la Croce nella sua corretta posizione e con la giusta orientazione, è un globo celeste pubblicato nel 1613 da Jodocus Hondius Junior e Adrian Vaen. Qui la Croce è rappresentata come una costellazione separata. La didascalia è scritta in latino e significa:"Il Cruzero spagnolo, ma le zampe del Centauro in Tolomeo."
 |
Il fatto che la Croce sia nata con un nome spagnolo non è affatto irrilevante. E' un altro argomento a favore dell'origine popolare di questa costellazione, in contrasto con tutte le altre costellazioni 'latine' moderne, che erano delle costruzioni artificiali di uno scienziato o di un altro. Questo fatto pone la Croce del Sud nella stessa categoria delle costellazioni tradizionali dei Greci, per molte delle quali è possibile ritrovare origini lontane, risalenti ai Caldei e ai Sumeri. La Croce risulta essere quindi l'unica costellazione 'naturale' dei nostri tempi.
Con questo arriviamo all'ultima parte del nostro argomento: il significato religioso della Croce del Sud. Non vi può essere alcun dubbio che per quei marinai spagnoli e portoghesi, lontani migliaia di chilometri da casa, la vista della Croce nel cielo deve essere stata una fonte di conforto, in una situazione piena di sofferenze e di paure. In quei tempi di miracoli e prodigi, era del tutto naturale che il più prezioso simbolo della loro Fede li precedesse nella conquista di nuovi mondi nel nome della Croce.
La differenza tra la Croce Cristiana del Sud e le costellazioni pagane del cielo boreale era ben nota. Nel diciassettesimo secolo vi fu perfino un tentativo di cristianizzare l'intero cielo stellato,
 |
Ma ha avuto la Croce qualche influenza nella storia dell'Emisfero Australe?
Sappiamo tutti che i 'conquistadores' fecero molto più uso della spada che
della croce nella colonizzazione di quelle nuove terre. E tuttavia le culture
che emersero da quel processo non furono del tutto prive dei valori morali
rappresentati dalla Croce, e non possiamo dire che la contemplazione notturna
di quelle 4 stelle, situate nella parte più bella del cielo, non abbia avuto
una certa influenza positiva nei cuori di quei marinai, sacerdoti, soldati,
contadini e operai di ogni specie che vissero, e ancora vivono nel Sud. Dopo
tutto, chi può negare che questo emisfero sia risultato più pacifico di quello
più antico, e che, o per i loro sforzi, o per la protezione divina, i popoli
australi siano riusciti a mantenere la loro parte del mondo fuori dalla
maggior parte delle guerre che hanno afflitto l'umanità nel ventesimo secolo
e già nei primi anni del ventunesimo!